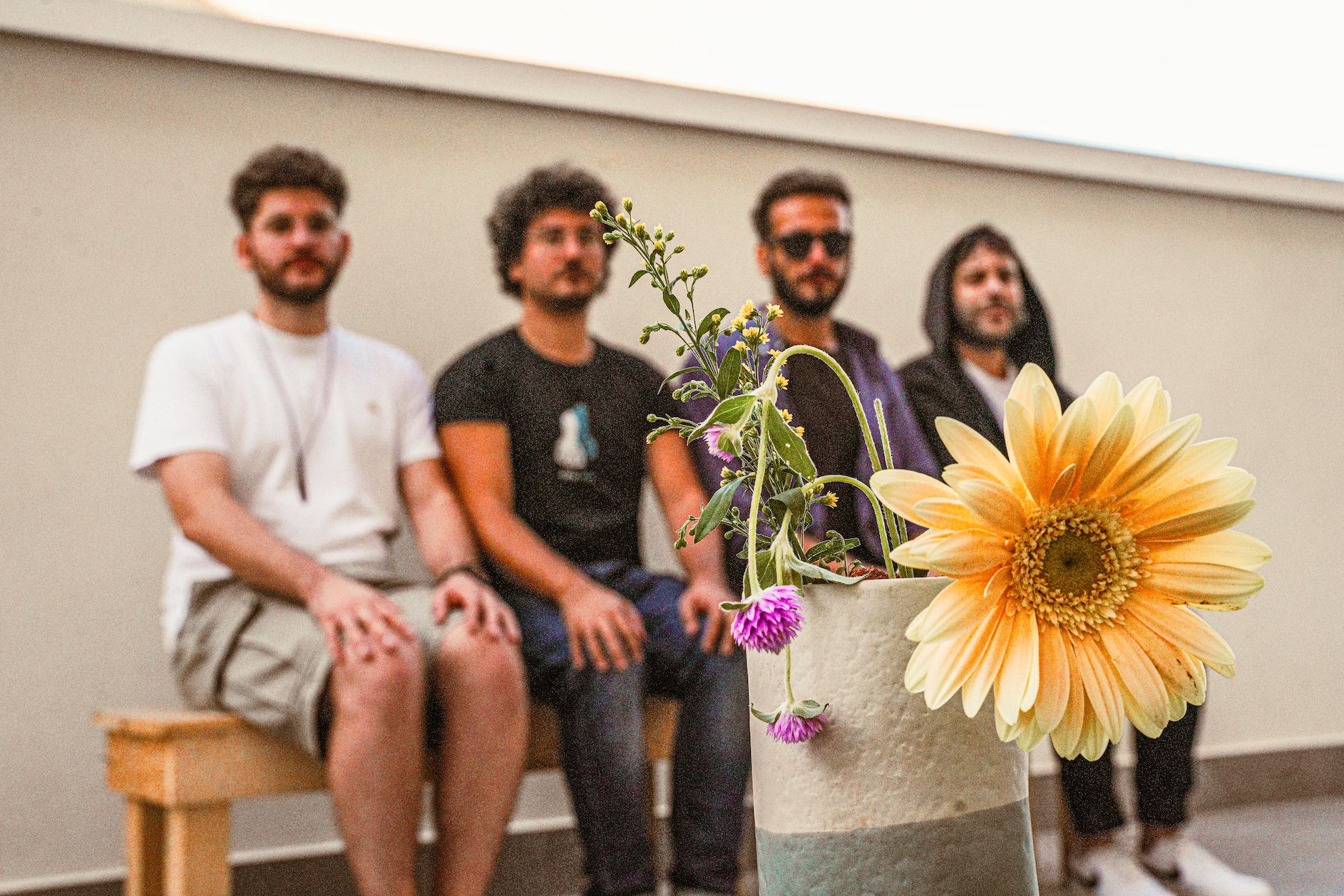È uscito il 13 dicembre 2024 e sarà disponibile in vinile e in cd dal 31 gennaio 2025 con distribuzione Goodfellas Poeti, Vampiri & Veneri Punk, il secondo album dei Panta, registrato tra Roma e i leggendari studi di Abbey Road a Londra (oltre che ai Battery Studios, altro luogo iconico), con la produzione di Paolo Violi.
Noi gli abbiamo chiesto di raccontarsi attraverso le loro 5 cose preferite.

La filmografia di David Lynch
David Lynch non è solo il mio regista preferito; senza di lui il progetto Panta non esisterebbe proprio. Ho avuto infatti il piacere e il privilegio raro di conoscerlo e di apprendere da lui della meditazione trascendentale, che ha sbloccato le mie energie migliori e il coraggio che mi serviva per diffondere ciò che scrivevo e suonavo. La pratico ormai da dieci anni, è la mia àncora quotidiana.

Giacche della tuta anni 90
Sarà che sono nato negli anni 90 e che quello stile – musicale ed estetico – è sempre parte delle mie corde più profonde, ma quanto sono belli i giacchetti delle tute di quel periodo! Sono uno dei capi che indosso di più anche quando mi esibisco, sento che dentro mi ci porto una storia, la stessa che racconto in un nostro brano intitolato 1990 (Come sentirsi vivi).

Il tè nelle tazze dei Beatles
Ho vissuto tanto tempo in Inghilterra e ho una passione smisurata per i tè e le tisane, con tutti i rituali annessi. Compresa la scelta delle tazze: i Beatles sono la band più importante per me e ho queste due tazze da sempre. È surreale oggi ricordare tutte le volte che avrò preso il tè con la tazza di Abbey Road sognando un giorno di suonarci. È successo qualcosa di ancora più bello: registrarci delle mie canzoni.

La Divina Commedia di Dante
Insieme alla musica, l’anima dei Panta è la letteratura. Sia perché è ciò che ho studiato all’università, sia perché scrivo e pubblico libri. Dante è da sempre la mia guida, un’ispirazione inesauribile per viaggiare in versi nel mondo terreno e ultraterreno. Leggerlo ravviva “l’amor che move il sole e le altre stelle” dentro e fuori di noi, qualcosa che ha influenzato alcuni dei miei artisti preferiti (e non ce lo si aspetta), come ho raccontato nel mio primo libro Poesia in forma di Rock: Nirvana, Radiohead, Bob Dylan, Joy Division e molti altri.

Cartoline dei quadri dei musei (e merch vario)
Visitare musei e viaggiare “alla ricerca d’arte” è una delle mie cose preferite al mondo. Ho una strana, intensa, sensazione di euforia e quiete al tempo stesso. Perciò da ogni visita torno con qualche cartolina (o merchandising vario, se ne vale la pena) dei quadri che più mi hanno colpito, soprattutto se mi sono esibito in quella particolare città. Qui c’è qualche riferimento: Magritte quando ho suonato a Bruxelles, Bacon a Londra, Cezanne ad Aix-en-Provence, Pellizza da Volpedo nelle Marche.